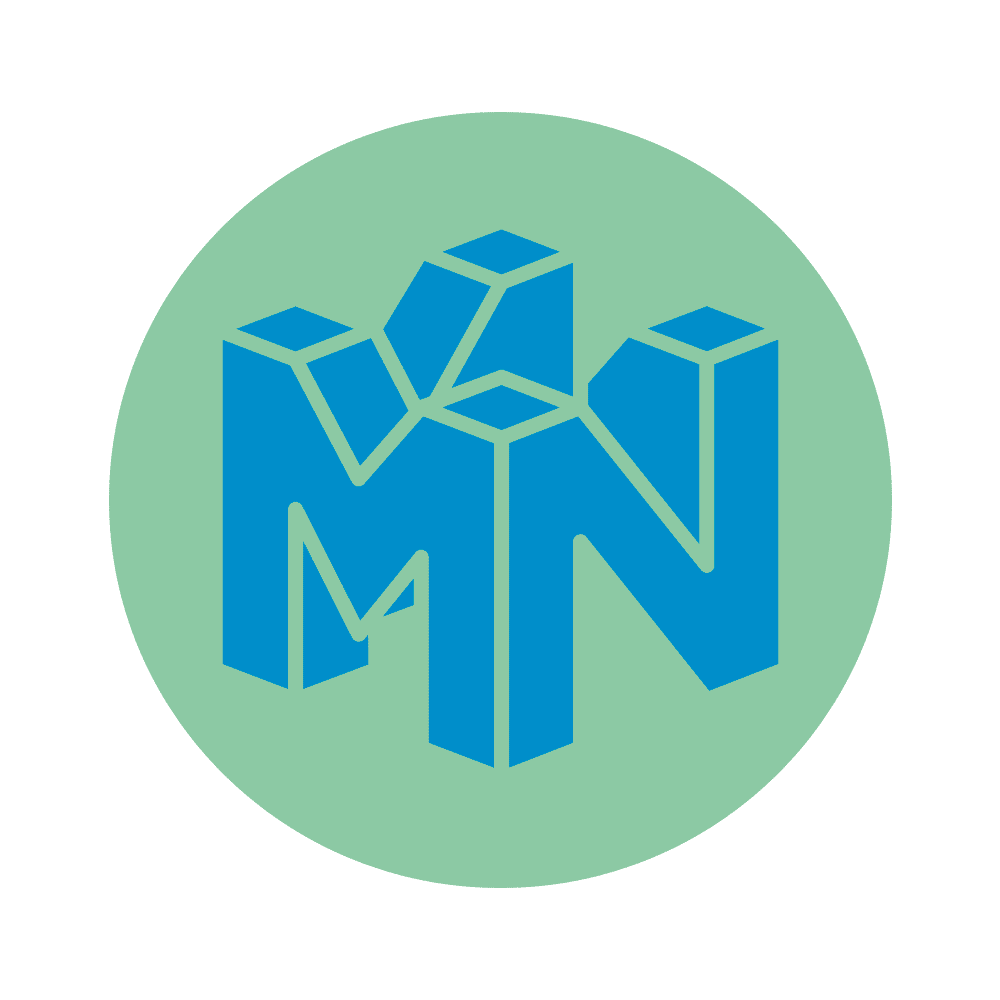Premessa: questo non è uno spot né una propaganda a Django Unchained. Quindi l’articolo va letto solo e soltanto dopo la visione. Detto fra noi, chi legge una recensione (o presunta tale) per sapere se andare a vedere un film come Django di Tarantino? Uno ci va e basta. E quindi, prima di tutto, il nostro consiglio è di andare. Poi ne parliamo.
*Inizio recensione e spoiler*
Onestà intellettuale e nessuna sudditanza psicologica di sorta. Ecco quello che ci vuole per scrivere qualcosa sull’ultimo film di  Quentin Tarantino. Chi digita sulla tastiera è un fervente ammiratore di gran parte del suo cinema, ma non un fan militante.
Quentin Tarantino. Chi digita sulla tastiera è un fervente ammiratore di gran parte del suo cinema, ma non un fan militante.
Il rischio più grande di uno come QT è quello di prendersi sul serio e credere troppo nella leggenda che già gli hanno costruito addosso. La sua dimensione è quella del genietto cazzone, di quello che scrive sui tovaglioli di un diner, che gira improvvisando soluzioni visive e salva sempre la giornata con le idee che gli derivano da quel frullatore di Cinema che ha al posto del cervello. In altri panni, tanto bene non ci sta. Insegnante, presidente di giuria a un festival, critico dei lavori altrui? No, davvero.

Senza guizzi di scrittura e/o salti ed ellissi temporali, il film si rivela lineare e, peggio, sceneggiato quasi col manualetto hollywoodiano aperto svogliatamente davanti. Presentazione dell’eroe, incontro col mentore, allenamento (ridicolo, non sbaglia mai un colpo), avventure varie, quest centrale, scomparsa del mentore, sconfitta, ritorno, vittoria. Con qualche variazione, sostanza di centinaia di pellicole. Niente di male (forse) se tutto fosse condotto alla Tarantino, no? Bene, Tarantino c’è ma non si vede, sembra una blanda spruzzatina su un piatto poco saporito.
DU non è neppure un western, in quanto mancano tutti gli elementi caratterizzanti e i miti  fondanti della retorica del West: questa è l’amata blaxploitation di Tarantino trasportata nell’America di fine Ottocento, non basta mettere uno sceriffo e qualche cavallo ogni tanto. Che poi a Tarantino i western mica piacciono, lui odia il genere classico e ama la sua deriva pop italiana. Che però detto tra noi, violenza grafica a parte (che sa più di Peckinpah) e qualche colpo ben piazzato, non è poi neppure tanto omaggiato – lasciamo perdere i 30 secondi di Franco Nero). Dov’è l’eroe solo contro tutti? Dov’è un antagonista degno di questo nome? I duelli? Dove sono i grandi ostacoli e le grandi difficoltà del protagonista? Non ce n’è traccia.
fondanti della retorica del West: questa è l’amata blaxploitation di Tarantino trasportata nell’America di fine Ottocento, non basta mettere uno sceriffo e qualche cavallo ogni tanto. Che poi a Tarantino i western mica piacciono, lui odia il genere classico e ama la sua deriva pop italiana. Che però detto tra noi, violenza grafica a parte (che sa più di Peckinpah) e qualche colpo ben piazzato, non è poi neppure tanto omaggiato – lasciamo perdere i 30 secondi di Franco Nero). Dov’è l’eroe solo contro tutti? Dov’è un antagonista degno di questo nome? I duelli? Dove sono i grandi ostacoli e le grandi difficoltà del protagonista? Non ce n’è traccia.
L’unica grande tortura di Django è sentirsi offendere e trattare come un animale da qualsiasi bifolco bianco incroci la sua strada? Un po’ poco, anche per chi non vuole sottovalutare il fenomeno dello schiavismo e la vergogna del razzismo. Tra l’altro diciamo subito che le polemiche create intorno alla pellicola sono cazzate micidiali e insensate. Però, se di razzismo e schiavismo vogliamo parlare, è indubitabile che esistono decine di pellicole che lo fanno in maniera migliore, più approfondita e più drammatica (in ogni senso) di DU.

Tarantino è più a suo agio con la decostruzione del pathos o la sua spasmodica dilatazione, non con le pratiche di un regista qualsiasi, che qui mette in atto, e il risultato è deludente. Esempio su tutti: il paio di occasioni in cui, a casa di Calvin Candie, prevedibilmente si creano situazioni di tensioni che involvono Broomhilda e prevedibilmente Django mette mano alla pistola, una reiterazione perfettamente inutile che non porta a niente, men che meno a un brivido per lo spettatore. Parlando di inutilità, vogliamo citare le decine di ralenti su gente che cammina a caso, in campo lungo, o su dettagli senza importanza? Meglio di no, ma ci sono, e li avete visti anche voi.
Tarantino pare caduto nella sindrome di Spielberg (che per un po’ ha avuto anche Jackson): non sempre tutto quello che ti piace e che vuoi realizzare perché hai la fortuna di poterlo fare si rivela un’operazione vincente. Non lo è stato A.I., non lo è stato King Kong, non lo è Django Unchained. In quest’ultimo caso, non lo è neppure lontanamente.
che vuoi realizzare perché hai la fortuna di poterlo fare si rivela un’operazione vincente. Non lo è stato A.I., non lo è stato King Kong, non lo è Django Unchained. In quest’ultimo caso, non lo è neppure lontanamente.
Al netto delle critiche espresse perché siamo di fronte ad un film di Quentin Tarantino – lo stesso motivo che porterà milioni di persone a dire che è un capolavoro e/o un lavoro coerente, brillante, etc – DU è e rimane un film piacevole, ben girato, con delle interpretazioni di spessore cristallino e inattaccabili e un piglio scanzonato come il discolo che non puoi punire perché in fondo è adorabile. Ma se vogliamo cercare del genio o dello stile inimitabile e irraggiungibile – quelle sciocchezze a cui QT ci ha abituato –, del Cinema con la maiuscola o qualcosa che rimarrà, è meglio rivolgersi altrove.