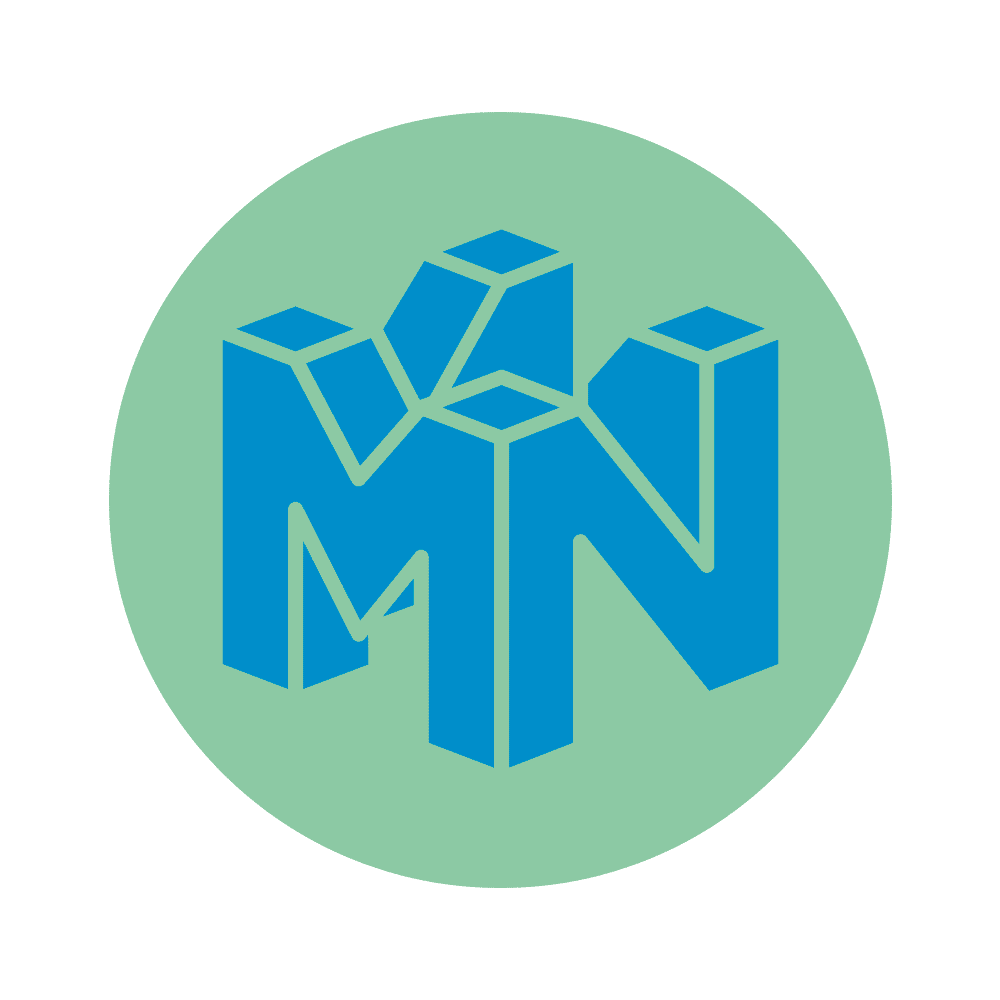We get the world we deserve / We deserve a better world.
Si chiude così, come un pendolo che oscilla tra nichilismo e speranza, la seconda stagione di True Detective, la serie investigativa antologica che ha portato su un altro livello i polizieschi televisivi americani.
Se il detto recita “squadra che vince non si cambia”, Nic Pizzolatto va in controtendenza: non solo cambiano protagonisti e ambientazione, ma anche regia e persino la sigla.
Dalla coppia Rustin Cohle – Marty Hart (Woody Harrelson e Matthew McConaughey) che indaga su un serial killer in Louisiana nell’arco di diciassette anni, al terzetto Ray Velcoro – Antigone “Ani” Bezzerides – Paul Woodrugh (a cui si aggiunge il losco imprenditore Frank Semyon) alle prese con l’omicidio di un uomo d’affari nella fittizia città californiana di Vinci.
Tagliamo subito la testa al toro: la nuova stagione è all’altezza del suo illustre e scomodo predecessore?
A mio parere, la risposta è: in gran parte NO, per vari motivi.
Partiamo da ciò che c’è di buono, e non è poco. Il comparto tecnico, anche senza l’eccellente lavoro di Cary Fukunaga in cabina di regia, rimane di altissimo livello, sia nelle scene più introspettive che in quelle più movimentate e frenetiche: la scena della sparatoria tra polizia e narcos nella quarta puntata non ha nulla da invidiare al grandioso piano sequenza di Rust infiltrato nella gang di biker nella prima stagione.
La colonna sonora (anche senza la magnifica “Far From Any Road” degli Handsome Family in apertura) è sempre azzeccata, con la particolarità della cantante nel bar che ricompare nei momenti chiave, come a ricoprire il ruolo del coro nelle tragedie greche.
Per quanto riguarda il cast, tanta era la curiosità – e la perplessità.
Personalmente ho trovato tutti gli attori all’altezza della situazione: in particolare Vince Vaughn, da molti criticato per una recitazione monocorde e poco espressiva, mi è parso invece ben calato nel ruolo più negativo tra i quattro protagonisti, abbastanza atipico rispetto alla sua carriera principalmente focalizzata sulle commedie disimpegnate.
Anche Colin Farrell riesce a esprimere adeguatamente i tormenti e le frustrazioni della situazione familiare e professionale del detective Velcoro, così come Taylor Kitsch, sebbene la sceneggiatura sacrifichi molto lo sviluppo del suo personaggio.
L’unica a non convincermi appieno è Rachel McAdams, anche se probabilmente dipende dal personaggio di Antigone, che a dispetto del nome letterario risulta l’elemento più piatto e monodimensionale del quartetto.
Proprio la gestione dei personaggi rappresenta una delle note dolenti.
I critici della prima stagione hanno contestato l’eccessivo carattere filosofico di Rust Cohle, che però costituiva un aspetto affascinante e innovativo rispetto ai tanti prodotti del genere: ed è innegabile che, nel corso delle puntate, venisse dedicato ampio spazio all’analisi psicologica dei due protagonisti.
A posteriori, passare da una situazione a 2 a una a 3+1, mantenendo invariato il numero degli episodi, non è stata una scelta saggia.
Molti spunti rimangono trascurati, e certe scelte dei personaggi (come l’amore improvviso tra Velcoro e la Bezzerides) risultano forzate e gratuite.
A farne le spese, come accennato in precedenza, è soprattutto il personaggio dell’agente Woodrugh, forse il più importante ai fini dell’indagine, che tra l’omosessualità repressa, la madre anaffettiva e il trauma della guerra, aveva molto materiale meritevole di approfondimento.
Anche la trama in senso stretto, con il vasto numero di soggetti e sottotrame intrecciati tra loro, diventa assai complessa da seguire, poiché il poco tempo a disposizione costringe gli sceneggiatori a comprimere passaggi e spiegazioni.
In sole otto puntate ci troviamo di fronte: una rapina in una gioielleria finita male, quasi vent’anni prima degli eventi narrati; il caso di una ragazza scomparsa; un giro di escort per le feste di potenti locali; un hard disk contenente video compromettenti di vari personaggi pubblici; il progetto di costruzione di una ferrovia, con tutte le manovre sporche su terreni e appalti che ne derivano; mafiosi russi e spacciatori messicani; il figlio del sindaco che vuole fare le scarpe al padre; la sorte dei figli dei gioiellieri uccisi nella rapina; lo stupro della moglie di Velcoro e la ricerca del colpevole.
Tanta, troppa carne al fuoco: seppure alla fine ogni tassello del complicato mosaico trovi la propria collocazione, l’impressione generale è poco lineare, intricata e confusionaria.
La narrazione procede quindi con molta lentezza, accelerando improvvisamente nella seconda parte.
Il finale, sotto certi aspetti ancora più “esplosivo” della prima stagione, può apparire ovvio e scontato, ma in fin dei conti è perfettamente logico.
Velcoro e Semyon rimagono vittime dei loro punti deboli che lo spettatore ha imparato a conoscere: per il primo, l’amore incondizionato per il figlio; per il secondo l’avidità e l’orgoglio.
Quanto all’esito della vicenda, Pizzolatto non è interessato a un happy ending canonico, perciò il messaggio conclusivo è più sulla linea del “nella vita reale vincono i cattivi”; il finale lascia giusto la porta socchiusa a indagini successive che, forse, inchioderanno i criminali alle loro responsabilità.
In sintesi, una stagione ben recitata e diretta, che merita di essere vista e richiede solo un po’ di pazienza e qualche rewatch per comprendere pienamente l’intreccio.
Non aspettatevi però di ritrovare il fascino esoterico e maligno di Carcosa e del Re Giallo, la simbologia alla “Apocalypse Now” e le riflessioni sull’animo umano: è un bel drama investigativo con violenza, corruzione e malaffare.