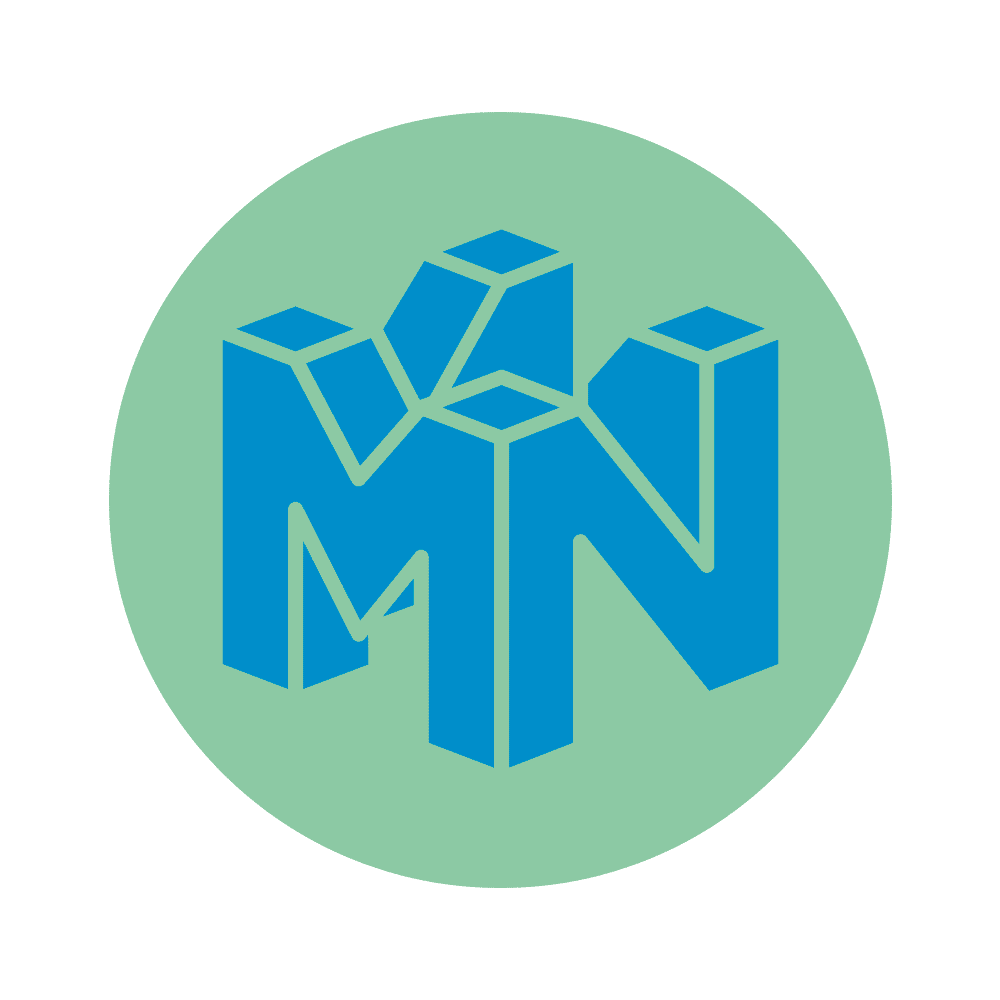Come si torna in scena dopo un capolavoro?
Non invidio Vince Gilligan, dico davvero. Per molti spettatori e appassionati, Breaking Bad rappresenta una pietra miliare, un caposaldo del genere drama che verrà ricordato e osannato negli anni a venire. La situazione in cui si è trovato il suo ideatore deve essere stata simile a quella dei Pink Floyd dopo Dark Side Of The Moon: da una parte la consapevolezza che un simile apice di creatività e ispirazione è destinato a non tornare, e dall’altra la spinta del pubblico, che non può averne abbastanza, vuole assaporare ancora quelle sensazioni, godere di altre meraviglie.
La soluzione più ovvia e “facile” è quella dello spin-off: una serie figlia di quella principale, che conserva alcuni personaggi ed esplora tematiche e storyline rimaste da parte. Ma il rischio di generare aspettative esagerate, di grattare il fondo del barile, allestendo un’operazione forzata solo per battere il ferro finchè è caldo, è sempre dietro l’angolo. La nona stagione di Scrubs è lì a ricordarcelo.

Partiamo dall’inizio: sappiamo che la serie ci spieghierà chi era Saul Goodman, ma intanto chi è adesso? Ecco che con un cold-open da brividi, tutto in bianco e nero, Gilligan ci mostra un anonimo impiegato di un fast-food nel Nebraska, sempre più calvo e coi baffoni, che vive nel terrore che un cliente possa riconoscerlo, e che finito il lavoro torna a casa, bicchiere in mano, e guarda in cassetta le registrazioni dei suoi vecchi spot. Uso magistrale del piano sequenza, colonna sonora anni ’40 (“Address Unknown” degli Ink Spots… come sempre nulla è lasciato al caso), tutto serve a rendere l’idea della disperazione esistenziale di chi voleva essere per Walter White quello che Tom Hagen era per don Vito Corleone, e ora ha perso, prima dei soldi e del successo, la propria identità.
Nel 2002, sette anni prima di Heisenberg e della blue meth, James “Jimmy” McGill non è messo tanto meglio: un avvocato pubblico costretto ad accettare cause assurde per clienti che non possono permettersi di meglio, con un fratello ex avvocato di fama costretto a ritirarsi da un’acuta elettrosensibilità (una presunta malattia che induce al terrore paranoico di qualsiasi campo elettrico o magnetico); ha il suo “studio” nel retrobottega di un salone di bellezza asiatico, è sommerso dalle bollette e guida un catorcio che, per sua stessa ammissione, varrebbe 500 dollari solo con una prostituta da 300 a bordo.

La doppia premiere (che, per la cronaca, ha battuto il record di ascolti per una premiere di una tv via cavo, con quasi 7 milioni di spettatori), mette in evidenza gran parte degli aspetti che hanno reso grande Breaking Bad: fotografia e montaggio impeccabili (la lunga sequenza di Jimmy tra tribunale e parcheggio, con la soggettiva della macchinetta del caffè che ritorna ciclicamente, è una gioia per gli occhi); la capacità di oscillare sempre tra il comico e il macabro, con un humour nero degno dei Coen più ispirati, come nel grottesco “patteggiamento” tra Jimmy e Tuco, seguita dalla scena dei grissini spezzati al ristorante, che fa sudare freddo il protagonista così come noi spettatori; il deserto del New Mexico, sinonimo di morte imminente e regolamenti di conti; e naturalmente, la verve del protagonista e la sua irrefrenabile parlantina, che magari gli tornerà poco utile in tribunale, ma intanto gli ha permesso di uscire sano – almeno lui – e salvo da una situazione in cui un altro, probabilmente, sarebbe finito sottoterra.
Gli unici difetti che per ora mi sembra di individuare sono il ritmo in certi passaggi ancora molto lento, specialmente nelle scene in cui compare il fratello Chuck, e l’assenza di un’adeguata spalla per il protagonista, che per ora regge la narrazione interamente da solo. Per il resto, le otto puntate rimanenti dovranno rispondere ad alcune domande: come ha fatto, nel dettaglio, un azzeccagarbugli la cui massima esperienza criminale sono le truffe sugli incidenti stradali, a diventare il Saul Goodman che tutti conosciamo? Qual è la vera natura del legame con il fratello Chuck, e come si evolverà? E come ha fatto Mike Ehrmantraut, finora solo uno zelante custode di parcheggio, a diventare il suo uomo del “lavoro sporco”?
In conclusione, questa serie ha tutte le carte in regola per lasciare il segno: se al primo episodio avrei dato un 6,5 di incoraggiamento, il secondo si merita un 8 pieno. I fan di BrBa si sentiranno immediatamente a casa, e gioiranno nel rivedere facce note e nello scovare piccoli dettagli e citazioni alla serie principale (l’inquadratura di Tuco che prepara la salsa, come quando aveva preso in ostaggio Walt e Jesse; o l’immagine di Jimmy a terra nel deserto, nella stessa posa di Walt con Gus Fring); gli altri si perderanno qualcosa, ma potranno comunque gustarsi una serie thriller – black comedy sicuramente ben fatta (vale comunque il consiglio, per non dire l’ordine, di fare ammenda e recuperare al più presto le cinque stagioni di Breaking Bad).
Che siate già fan di Vince Gilligan o meno, l’invito è lo stesso: better watch Saul!